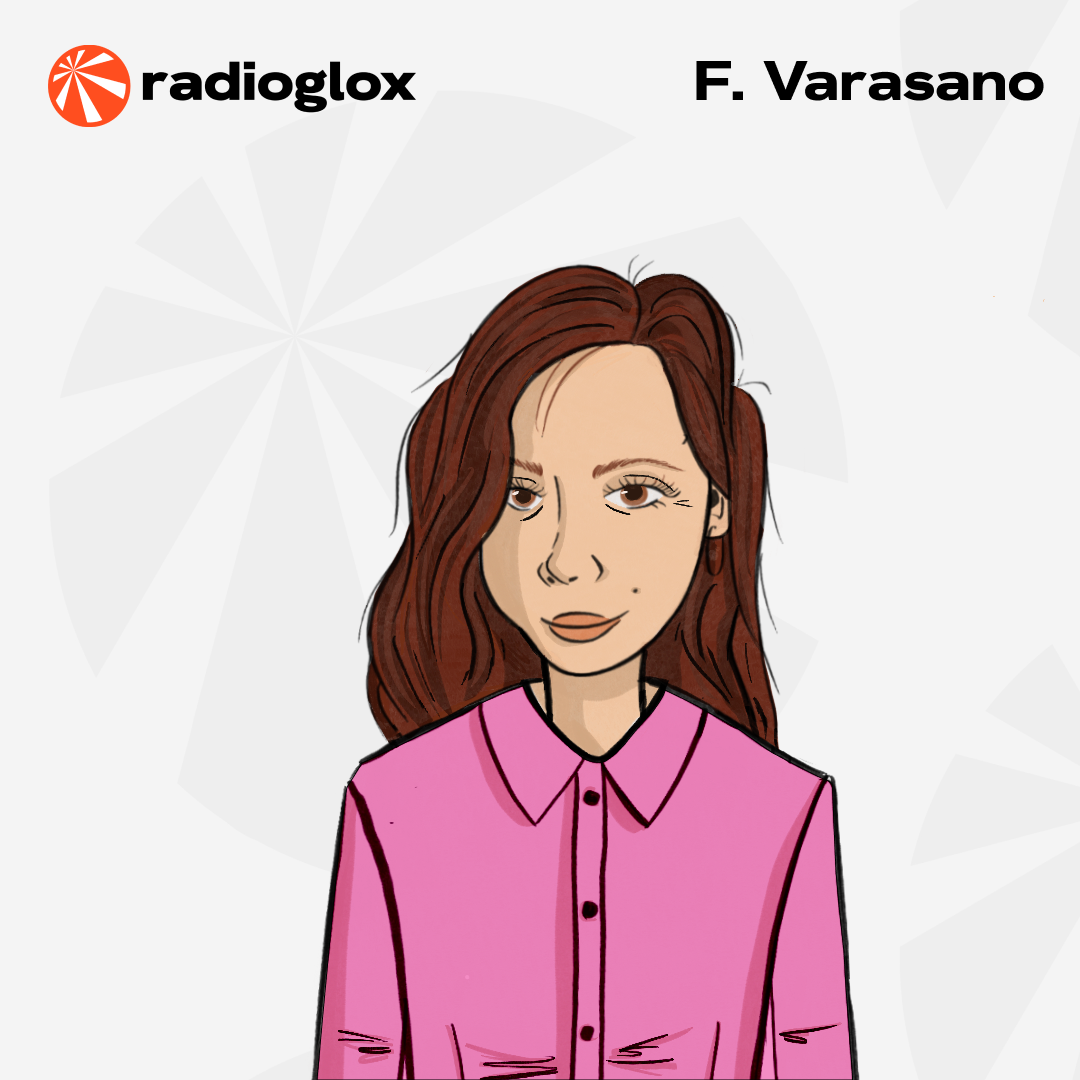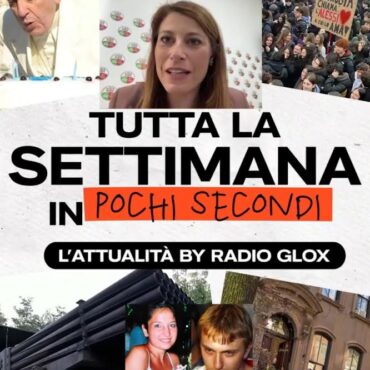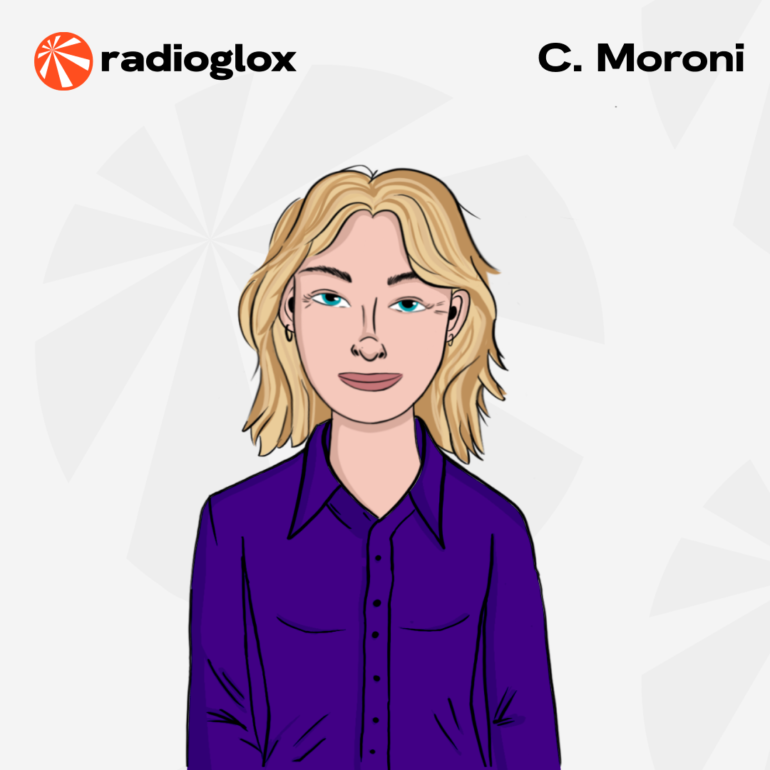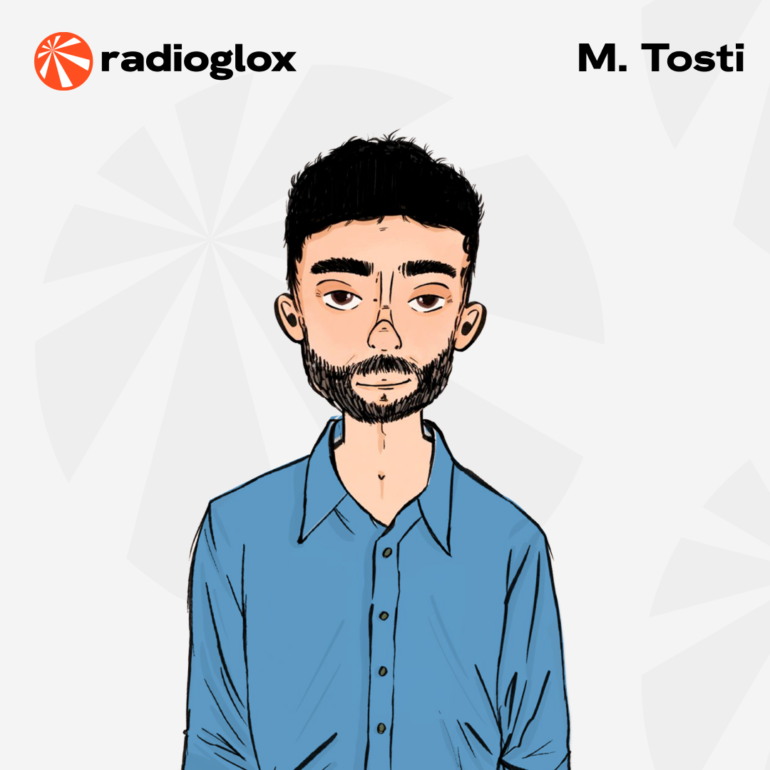Poco lontano da Kyiv, il giovane filosofo Choma Brut ha ucciso una strega in quello che sembrava un sogno. Ma la strega, racconta Gogol’, in realtà era la figlia di un ricco cosacco, e in punto di morte ha chiesto al padre che proprio Choma vegli sul suo corpo per tre notti. Choma non ha scelta, il cosacco lo esige. La prima notte, con stridore di denti, la strega si alza dalla sua bara ma Choma riesce a tenerla lontana. La seconda notte lo insegue con incantesimi, e al mattino Choma è più morto che vivo. La terza notte la strega evoca lo spaventoso demone Vij (che dà il titolo al racconto): Vij è una creatura maligna con ciglia lunghe fino a terra e volto e pugni di ferro, con cui annienta Choma. Poco tempo dopo, ricordando Choma, i suoi amici (che non hanno conosciuto la strega e non ne hanno vegliato il corpo, e men che meno hanno visto il demone), ne commentano la morte concludendo più o meno così: povero Choma, certo, ma insomma bastava avere un po’ di coraggio.
Bastava fare un accordo diplomatico prima. Basta guerre, vogliamo la pace. Ma bastava arrendersi subito, è la legge del più forte! (quelli che proprio la sanno lunga). Opinioni e tautologie di questo tenore sul conflitto in Ucraina sono all’ordine del giorno: le leggiamo, le ascoltiamo, magari restiamo interdetti. Frasi fatte, il nemico del pensiero originale, si ripetono intorno a noi come un ritornello, senza ammettere contraddittorio. L’Europa, per esempio, dovrebbe battere un colpo (eppure nelle ultime settimane l’Europa, o per meglio dire l’Unione Europea, ha riunito a Londra – scelta non casuale – i primi ministri degli stati membri insieme appunto al Regno Unito, al Canada, e pure alla Turchia, partner al momento cruciali; l’UE discute di difesa comune e ha lanciato al tempo stesso un accordo commerciale con l’India). Europa sì, ma non questa Europa! Dicono, o più spesso scrivono, gli altri, i più illuminati (come se ce ne fosse un’altra a portata di mano, come se non ci fossero voluti decenni per arrivare all’integrazione che abbiamo oggi, come se mettere insieme quasi trenta stati di lingua e culture diverse non fosse necessariamente un compromesso, ma sia ragionevole pretendere un’organizzazione che si adatti ai nostri desideri minuti. Come se per costruire quello che abbiamo in questo continente non si sia partiti – letteralmente – da lacrime, sangue, e macerie).
Negli ultimi anni, la politica tutta (italiana, europea, mondiale) ci ha di buon grado abituati allo spettacolo anteposto al servizio pubblico, al linguaggio ricco di effetto e scarso di significato, in una sorta di campagna elettorale permanente a chi riceve più consensi sui social media, a chi per primo comprime fatti complessi su Twitter (anzi X) in meno di 200 caratteri, a chi si fa notare per una ragione qualunque, come se fosse un reality show. Ed ecco allora la politica dei non sequitur, le felpe, le dichiarazioni sulla fine della povertà o i proclami altisonanti d’aver scritto la storia. I selfie su Facebook, le motoseghe brandite da un palco, i covfefe (non è un refuso, ma un tweet di qualche anno fa di Donald Trump. Purché sia veloce, appunto, non importa che abbia significato, e non importa neppure che sia una parola in una lingua conosciuta). Se anche il nostro sentire politico fosse oggi sotto anestesia, non venga meno il senso del ridicolo.Rire pour résister, ridere per resistere, titolava lo scorso numero della rivista francese Le Point, perché una cosa forse hanno in comune le derive autoritarie di ogni tempo e luogo: sono (anche) ridicole. La pomposità o l’inconsistenza del linguaggio, magari i riti ampollosi, il re nudo che sbatte i pugni sul tavolo per ricordarci che appunto è lui il Re, ma anche lo sforzo patetico e ad oltranza di assomigliarci, di assomigliare a noi sostenitori (clienti permanenti di un prodotto scadente da social media): un tentativo maldestro di vernice a quello che in realtà è semplicemente ridicolo. Le barzellette di età sovietica erano celebri e fulminanti, una satira impietosa di tempi tragici (“Ma come è possibile che prima della rivoluzione d’ottobre il popolo russo sopportasse la terribile oppressione zarista?”, dice una, “Pensava a quello che sarebbe venuto dopo e dunque cercava di tenersela il più a lungo possibile”). Un proverbio apocrifo gira oggi con insistenza sui social media: “se un pagliaccio entra a palazzo il pagliaccio non diventa re, ma il palazzo diventa un circo”.
L’opinione pubblica esiste solo quando mancano idee, secondo un celebre aforisma di Oscar Wilde; o forse, invece, l’opinione pubblica siamo noi, e ognuno di noi nel suo piccolo, col suo sentire sociale e la propria bussola morale, interpreta la realtà in cui vive e, così facendo, contribuisce a plasmarla per sé e per gli altri intorno a noi, in un confronto civile che si può ancora sottrarre al ridicolo, alle urla che ci circondano senza posa (ancora un altro tweet, ancora un altro post). Non la storia noi scriviamo (grazie a Dio), ma al massimo una biografia: come ci rapportiamo al tempo che ci è dato vivere, un testamento del nostro carattere, la nostra motivazione intrinseca. Sperando sempre di non incontrare streghe e demoni, se ne abbiamo l’opportunità ascoltiamo il racconto di chi invece lo ha fatto, prima di saltare a conclusioni in cento caratteri o anche meno.
Francesca Varasano